Il wushu e la Cina: il racconto di una lunga storia d’amore
Come accennavo sopra, sono stato uno degli ultimi a vivere il boom del kungfu in Italia, che è durato all’incirca fino alla fine degli anni ‘80 e primi anni ‘90. Quando i miei genitori si decisero a iscrivermi a un corso di kungfu non avevo ancora compiuto 8 anni. Di quel lontano ottobre del 1987 ricordo solo due cose in particolare: la forte emozione, paragonabile solamente a quella provata in occasione del mio primissimo viaggio in Cina (che feci undici anni più tardi, per partecipare a una competizione), e le parole del direttore del centro sportivo, il quale cercò in qualche modo di dissuadere mia madre perché, a suo dire, ero ancora troppo piccolo: “Va bene signora. Gli faccia fare una lezione di prova. Vedrà che sarà lui stesso a rendersi conto che è ancora troppo piccolo per il kungfu”. In realtà, rimasi con il mio primo maestro, Michele, per altri quattro anni.
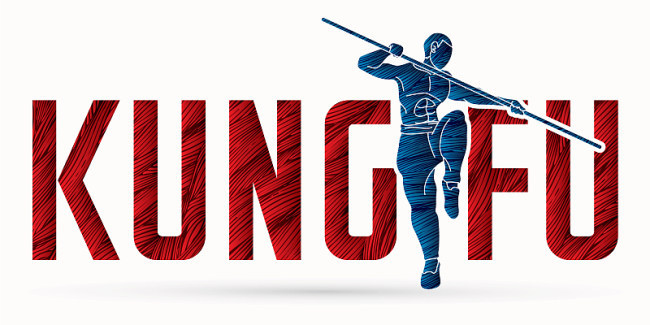
A partire dalla seconda metà degli anni ‘90 cominciò ad arrivare in Italia anche la versione sportiva del wushu cinese, che tra i praticanti italiani è conosciuta come “wushu moderno”, per differenziarlo dalla sua variante “tradizionale” la quale, per convenzione, si è soliti chiamare in italiano kungfu. Il caso ha voluto che già all’età di 16 anni mi si presentò l’occasione di frequentare un corso curato dal maestro Angelo Rossi, il quale era tornato da pochi mesi in Italia dopo un lungo periodo di studio e perfezionamento presso lo Shanghai Wushu Institute. E fu così che la mia vita ebbe una svolta. Con il maestro Rossi ho studiato wushu moderno e tradizionale dal 1996 al 2004 e, in seguito, ho arricchito il mio bagaglio tecnico nel taijiquan. Grazie al maestro Rossi, con il quale condivido oggi una profonda amicizia, feci anche i miei primi due viaggi in Cina, nel 1998 e nel 2002. Nel frattempo, mi sono iscritto all’università dove studiai lingua e cultura cinese, per rimanere fedele al mio amore di sempre.
Sono ormai trascorsi più di trent’anni da quando ho tirato il mio primo pugno in palestra. Nell’arco di questo lungo periodo, il mio legame con il Paese che ha dato i natali a Confucio e Mencio è continuato a crescere e ad approfondirsi. Sebbene la mia passione sia sempre la stessa, con gli anni è cambiato il modo in cui intendo le arti marziali e il motivo per cui le pratico. Quando mi alleno, lo faccio in parte per rinnovare il mio personale rapporto con la cultura cinese, esperendone attraverso il corpo la sua filosofia antica e ricercando, allo stesso tempo, di entrare in contatto con la parte più vera di me stesso, dando voce nel movimento al mio essere. Vivo la pratica come un’esperienza profonda di auto-coltivazione spirituale, come una forma di costante ricerca introspettiva. Ma, allo stesso tempo, rifuggo da una visione “new age” e “falsamente interiore” della disciplina. La pratica è qualcosa di molto concreto e pragmatico, richiede attenzione ai dettagli, precisione nell’esecuzione ed un’elevata capacità di dosare in maniera corretta la forza. Non è niente di più e niente di meno di un allenamento fisico e mentale, che culmina nel superamento della distinzione stessa tra mente e corpo. Questa visione è certamente influenzata dallo stesso taijiquan, il quale enfatizza più di altri stili la dimensione interiore dell’arte marziale, con forti richiami alla cultura tradizionale neoconfuciana.
Viste da fuori le arti marziali possono sembrare solo un modo per imparare a “tirare calci e pugni” e credo che questo sia anche, ad esempio, uno dei principali motivi della popolarità di cui godono oggigiorno le MMA (Mixed Martial Arts), da molti considerate come la massima espressione degli sport da combattimento. Ritengo però che, a differenza di queste ultime, il wushu cinese - in tutte quelle che sono le sue varianti e stili - abbia qualcosa in più, non tanto a livello tecnico o pragmatico, quanto da un punto di vista strettamente culturale: il wushu è il frutto di un sapere tradizionale tramandato per secoli, una disciplina che trasmette a chi la pratica tutta una serie di valori finalizzati alla maturazione complessiva della persona, prima ancora che del combattente o dell’atleta. È uno stile di vita che ha assorbito in maniera talmente profonda aspetti della cultura cinese tradizionale da diventarne un simbolo. Ed è esattamente per questo che mi risulta praticamente impossibile pensare a quest’hobby, che coltivo da quando sono piccolo, in maniera indipendente dalla mia formazione sinologica. Le due cose sono interconnesse tra loro.
La passione che nutro per la Cina è, infatti, da sempre strettamente legata alle arti marziali. Per quanto queste ultime possano essere uno degli aspetti della cultura cinese che generalmente esercita un certo fascino su noi occidentali, credo però che nel mio caso specifico esse rappresentino qualcosa di ancor più profondo, di molto più intimo. Ed è sempre attraverso le arti marziali che, per la prima volta, mi sono sentito veramente accettato da questo Paese, non più visto soltanto come un laowai (uno straniero), ma semplicemente come un praticante. Così, ogni volta che mi alleno, non lo faccio solo per me stesso o in segno di rispetto verso la figura del maestro, ma anche per ringraziare la Cina che mi ha accolto e, a suo modo, ha saputo contraccambiare tutto l’amore che provo per lei.